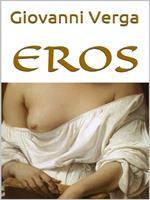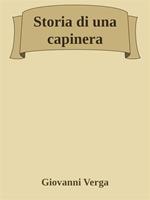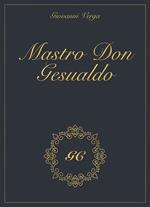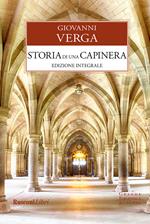Nato da famiglia di nobili origini e di tradizioni liberali, Giovanni Carmelo Verga crebbe alla scuola di Antonino Abate, esponente di una letteratura civile di ascendenza byroniana e guerrazziana. Verga può accedere a un’adeguata istruzione e viaggiare fuori dalla Sicilia, stabilendosi a Firenze e Milano, dove frequenta salotti e ambienti mondani. La prima fase della sua carriera di scrittore vede dunque romanzi di maniera, influenzati dal Romanticismo e dalla Scapigliatura. La sua prima prova romanzesca, "Amore e patria" (1856-57, inedito; tre capitoli ne furono pubblicati nel 1929), esce da quell’arroventata officina provinciale e affianca all’approssimazione linguistica l’enfasi patriottica. L’esordio pubblico avvenne nel 1861 con I carbonari della montagna, una storia collocata nella Calabria dei primi moti carbonari, ma che riflette motivazioni etiche e politiche dello scrittore ventenne, arruolatosi durante l’impresa garibaldina nella guardia nazionale e impegnato in attività pubblicistiche di forte ispirazione unitaria. Macchinosità e goffaggine di scrittura relegano I carbonari in una preistoria verghiana, in cui resta confinato anche "Sulle lagune" (1863), che chiude la trilogia catanese d’ispirazione patriottica ma nel quale si possono cogliere i segni di una prima «conversione», dal romanticismo eroico a quello passionale. Il passaggio è documentato dalla sostituzione della figura dell’artista a quella dell’eroe nei successivi romanzi: "Una peccatrice" (1866) narra infatti l’avventura di un giovane scrittore esordiente; ovvio il riferimento autobiografico, anche se V. prende le distanze dal suo nuovo eroe, come da quelli successivi della serie dei romanzi passionali, inserendo tra accaduto e narrato il filtro di un narratore. L’opera che di colpo fece uscire V. dalla clandestinità letteraria e presto s’impose come un best seller fu "Storia di una capinera" (1871); essa esibiva due ragioni di popolarità: il motivo manzoniano della monacazione forzata e la struggente confessione di un amore impossibile che condanna alla follia e alla morte.
Intanto, trasferitosi nel 1869 a Firenze, V. aveva avuto modo di conoscere l’ambiente letterario della città, in quegli anni capitale d’Italia (fra l’altro strinse rapporti con F. Dall’Ongaro). Nel 1872 si stabilì a Milano, entrando in relazione con scrittori quali A. Boito e G. Giacosa e frequentando i ritrovi letterari della città (in particolare il salotto della contessa Maffei). Le opere di quegli anni hanno uno schema simile a Una peccatrice: in "Eva" (1873) si consuma il tema dell’artista vittima dell’amore e della società, nel quale sono ravvisabili influenze della scapigliatura ma anche indizi autobiografici, mentre il dittico "Eros" (1874) e "Tigre reale" (1875) sposta l’obiettivo sull’eroe della mondanità, uomo o donna «di lusso».
LA «CONVERSIONE» AL VERISMO. DA «NEDDA» A «I MALAVOGLIA». Nel 1874 però V. aveva anche pubblicato il «bozzetto siciliano» "Nedda", con cui inaugurava un genere non ancora tentato e nel quale in quegli anni continuò a cimentarsi: la novella. Ma ciò che più conta è la parsimonia dei mezzi stilistici lì adibiti alla rappresentazione di un destino lasciato senza riscatto né umano né sociale, oltre alla scelta di un argomento «umile» come la vicenda di una misera raccoglitrice di olive siciliana. È quello che viene considerato l’inizio di una nuova maniera verghiana, che trovò compiuta espressione nei "Malavoglia" * (1881), primo di una progettata serie di cinque romanzi (ciclo dei Vinti). Nei Malavoglia sono chiari i cardini della nuova concezione veristica di V.: da una parte l’individuazione di un «punto di vista» che consenta al narratore di calarsi nei fatti e quasi scomparire, lasciando che questi si producano da sé come per una necessità naturale, cancellando la mano dell’autore; dall’altra il progetto di tipo balzachiano e zoliano del ciclo. Nei risultati, comunque, più dell’ambizioso progetto sociologico, presentato nella prefazione al romanzo come lo studio dei meccanismi che determinano la darwiniana lotta per la vita e le leggi del progresso umano, è valida la prima istanza di rappresentazione o, come dirà lo stesso V., «illusione» della realtà: un’istanza linguistica ed espressiva che rende conto della diversità dei livelli e registri narrativi tra le grandi opere del V. maturo. Evitando di dar voce direttamente alle proprie reazioni etiche, ideologiche, affettive, lo scrittore persegue l’obiettivo di orchestrare la materia sull’intonazione di una voce narrante, ritmata su una cadenza locale immune da compiacimenti dialettali e su una sintassi mimetica che restituisca l’elementarità e insieme l’eloquenza, la sentenziosa proverbialità del parlato, e cali il lettore nel ritmo naturale del vissuto. V. si immerge nel mondo sociale di Aci Trezza, nella semplice e insieme rissosa comunità che sta attorno ai protagonisti, i Toscano detti i Malavoglia, e si confronta con i miti di quell’umanità elementare: l’«ideale dell’ostrica» come difesa dall’urto della marea, da cui tuttavia tutti gli eroi del romanzo sono investiti dopo il naufragio della «Provvidenza» (la barca dei Malavoglia) che avvia la vicenda; la «religione della famiglia» incarnata dal patriarca della «casa del nespolo», il biblico padron ’Ntoni, ed ereditata dal mite Alessi; la «vaghezza dell’ignoto» che getta gli inquieti, il giovane ’Ntoni e la sorella Lia, in bocca al mondo, «pesce vorace» che inghiotte coloro che spezzano il vincolo tutelare della comunità.
LE NOVELLE E I DRAMMI. Negli stessi anni in cui lavorava ai "Malavoglia", V. scriveva pure alcune delle sue novelle più riuscite: la serie di "Vita dei campi" (1880), che comprende un’anticipazione di tono colloquiale dei motivi del romanzo "Fantasticheria", ed è dedicata ai «primitivi» ("La lupa", "Jeli il pastore") e ai dannati della terra ("Rosso Malpelo"), e la serie delle "Novelle rusticane" (1883), dove la materia si articola in un contesto di rapporti storico-sociali ed economici più evoluti, ma anche fortemente drammatici (Libertà) e ossessivi (Malaria, La roba). Alla maniera mondana e sentimentale va invece ricondotto il romanzo Il marito di Elena (1882), mentre le altre raccolte di novelle, Per le vie (1883), "Vagabondaggio" (1887), "I ricordi del capitano d’Arce" (1891), "Don Candeloro e C.i" (1894), attingono anche a una vena populista. Dalle novelle inoltre V. traeva materia di drammi: nel 1894 il grande successo di "Cavalleria rusticana" inaugurava il verismo a teatro in quella tipica veste regionale ed «elementare» tanto cara al repertorio di fine secolo. Minore fu la fortuna di altri drammi: "In portineria" (1885); "La lupa" (1896), iscritta però duraturamente nel repertorio passionale delle grandi attrici; "Caccia al lupo" (1901); "Caccia alla volpe" (1901).
«MASTRO-DON GESUALDO». Del 1889 è il secondo grande romanzo di V., Mastro-don Gesualdo*, già pubblicato in rivista l’anno precedente, ma con varianti significative. L’impianto narrativo, più ampio che nei Malavoglia, è quello di un romanzo di costume; il montaggio degli episodi è per successione di quadri, ognuno dei quali svolge un tema, senza che lo scrittore, fedele alla poetica dell’impersonalità, intervenga: dal quadro d’apertura dell’incendio di palazzo Trao a Vizzini, che scopre la rovina materiale e morale del nobile casato, a quello finale della solitaria morte a Palermo, nella foresteria del duca di Leyra, tra l’irrisione della servitù, dell’ormai rassegnato protagonista. Anche la morte è qui spogliata di ogni solennità, consegnata alla commedia di chi sopravvive. Nel sovrapporsi chiassoso di voci che incrinano ogni valore sociale V. sembra aver individuato il ritmo espressivo di un’umanità condizionata dal denaro, condannata alla solitudine. È una condizione di cui i personaggi non hanno coscienza né avvertono il disagio, diversamente dai protagonisti dei romanzi giovanili. Per questo "Mastro-don Gesualdo", più che un ultimo grande prodotto della tradizione ottocentesca, appare come il primo romanzo italiano dell’alienazione borghese.
Con "Mastro-don Gesualdo" il dittico narrativo fondato sulle due «religioni», o miti sociali, della famiglia e della roba si era realizzato, lasciando sospesa l’attuazione del grande ciclo dei Vinti: il successivo romanzo "La duchessa di Leyra" rimase incompiuto, mentre gli altri due previsti ("L’onorevole Scipioni" e "L’uomo di lusso") non furono nemmeno iniziati. All’estrema attività dello scrittore appartengono l’altro romanzo "Dal tuo al mio" (1906), una sarcastica e amara parabola dei conflitti sociali, adattato subito dopo per il teatro, e alcune novelle.
Gli ultimi anni V. li trascorse a Catania, chiuso in uno scontroso isolamento e in un lungo silenzio. Egli aveva trovato nel verismo un metodo per creare in letteratura un correlativo «naturale» della realtà e liberare la prosa italiana dall’artificio; per questo preferì tacere quando quel metodo non sembrò più coincidere con la sua materia. Ma la critica aveva da tempo riconosciuto il suo rilievo di innovatore e il suo magistero d’artista, a cominciare da L. Capuana, che ne predisse ed esaltò la grandezza, e B. Croce. In seguito si sono avuti i contributi di L. Russo, G. Devoto, L. Spitzer, il dibattito marxista sulla poetica e l’ideologia verghiana, quindi il lavoro della filologia, nuove analisi del testo e nuove interpretazioni generali.
«I Malavoglia, Mastro-don Gesualdo, la Duchessa de Leyra, l'Onorevole Scipioni, l'Uomo di lusso sono altrettanti vinti che la corrente ha deposti sulla riva, dopo averli travolti e annegati, ciascuno colle stimate del suo peccato, che avrebbero dovuto essere lo sfolgorare della sua virtù. Chi osserva questo spettacolo non ha diritti di giudicarlo; è già molto se riesce a trarsi un istante fuori dal campo della lotta per studiarla senza passione, e rendere la scena nettamente, coi colori adatti, tale da dare la rappresentazione della realtà, com’è stata, o come avrebbe dovuto essere.» - Giovanni Verga, Prefazione a "I Malavoglia", 19 gennaio 1881